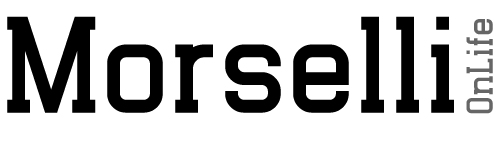Guido Morselli nasce a Bologna il 15 agosto 1912 da genitori emiliani. La madre, Olga Vincenzi, figlia di un noto avvocato bolognese, muore quando Guido ha dodici anni. Il padre, Giovanni, sarà amministratore delegato e presidente della manifattura di farmaci Carlo Erba di Milano per quasi quarant’anni, oltre che deputato delle Corporazioni al Parlamento durante il ventennio fascista e presidente dell’Associazione nazionale dell’industria chimica.
Guido Morselli nasce a Bologna il 15 agosto 1912 da genitori emiliani. La madre, Olga Vincenzi, figlia di un noto avvocato bolognese, muore quando Guido ha dodici anni. Il padre, Giovanni, sarà amministratore delegato e presidente della manifattura di farmaci Carlo Erba di Milano per quasi quarant’anni, oltre che deputato delle Corporazioni al Parlamento durante il ventennio fascista e presidente dell’Associazione nazionale dell’industria chimica.
Per il primo figlio maschio, tale padre desidera una carriera da avvocato: Guido si laurea in Legge nel 1935 a Milano, dove la famiglia si è trasferita, contenendo la predilezione per la filosofia a cui lo avrebbero avviato le amate lezioni del suo professore al liceo Parini, Antonio Banfi. Divenuto allievo ufficiale degli Alpini a Bassano del Grappa, Guido rinuncia presto al posto di lavoro alla Caffaro trovatogli dal padre, e nel 1938 ottiene da questi un vitalizio che gli permetterà di dedicare l’esistenza alla lettura e alla scrittura, affiancate da un interesse non marginale per la natura.
Lo stesso anno Giovanni Morselli, che dal 1916 possiede una villa in via Limido a Varese, acquista dei terreni a Gavirate. Trascorsi gli anni della seconda guerra mondiale prima in Valle Susa, poi sull’isola sarda di Sant’Antioco, quindi all’Accademia militare di Modena e, per tre anni, in Calabria, in fanteria, rientrato a Varese Guido frequenta con assiduità queste zone boschive a nord-ovest del centro cittadino: vi si trasferisce piuttosto stabilmente a partire dagli anni Cinquanta, in una casa disegnata da lui (priva di telefono e di elettrodomestici), nella località il Sasso di Gavirate .
Abbandonatala nel 1972 per dei fastidiosi disturbi dai quali si sentiva minacciato – più che dall’«invasione» dei ghiri, per la quale aveva chiesto consiglio persino a Konrad Lorenz (interpellato per lettera nel 1968) –, si toglie la vita la notte del 31 luglio 1973 a Varese in via Goldoni, nella casa dei custodi della villa di via Limido.
Malgrado una vita apparentemente inoperosa, come dovette apparire al «concretissimo» padre, rammaricato dall’«estraneità al “fiume sociale”» di un figlio che «nella società di allora (e anche di oggi) non era nessuno» (così il fratello Mario), Morselli ebbe una dedizione non comune al lavoro, ovvero allo studio e alla scrittura. Lo rivelarono alla sua morte la biblioteca personale, aggiornata e ricca di appunti e inserti, che si conserva nei fondi bibliotecari del Comune di Varese , e le numerosissime pagine di prosa narrativa e saggistica che lasciò (a suo dispetto) quasi del tutto inedite, e che nel 1994 confluirono nel patrimonio del Centro per gli studi sulla tradizione manoscritta di Autori moderni e contemporanei dell’Università di Pavia, donazione dell’erede Loredana Visconti Merchiori, figlia della sorella minore di Guido.
Oltre ad alcuni articoli su testate giornalistiche, in vita Morselli aveva pubblicato solo il saggio Proust o del sentimento con Garzanti, prefato da Antonio Banfi (1943), e i dialoghi Realismo e fantasia con Bocca (1947). Solo dopo la sua prematura scomparsa videro la luce, con le edizioni Adelphi, i romanzi che rivelarono un maestro nascosto della narrativa del Novecento: Roma senza papa (1974), Divertimento 1889 e Contro-passato prossimo (1975), Il comunista (1976), Dissipatio H.G. (1977), Un dramma borghese (1978), Incontro col comunista (1980), Uomini e amori (1998), oltre al saggio Fede e critica (1977). Pagine che erano state ignorate da «uomini di cultura ed editori» con una «costanza di distrazione e di rifiuto» da cui si diceva ferita Maria Corti, tormentata da «inesauribili interrogativi» di fronte ai «cinque grandi scatoloni» accolti nel suo Centro manoscritti.
Oggi è noto come la penna di Morselli, impegnata anche in un fitto resoconto diaristico quotidiano, solo parzialmente testimoniato dalla selezione proposta nel Diario da Valentina Fortichiari e Giuseppe Pontiggia (sempre Adelphi, 1988), abbia intrecciato narrativa, storia, fantascienza e filosofia, affrontando inoltre magistralmente il genere breve del racconto, il respiro saggistico e il taglio giornalistico: si pensi agli articoli riuniti in La felicità non è un lusso (1994), ai racconti raccolti in Una missione fortunata (Nuova Editrice Magenta 1999) e nel recente Gli ultimi eroi (il Saggiatore 2024), a cura di Giorgio Galetto, Fabio Pierangeli e Linda Terziroli, dove sono confluiti anche gli inediti progetti cinematografici.
Non si era, invece, ancora fatta conoscere la vena lessicografica dell’eclettico scrittore, capace di cambiare così spesso «pelle letteraria», con le parole di Dante Isella: il Dizionario dietetico, di cui Isella seppe abbastanza da considerarlo un progetto «curioso», è in realtà l’insospettabile premessa dei grandi romanzi per i quali era noto, ad oggi, Guido Morselli.
Testo di Elena Valentina Maiolini
Bibliografia essenziale
Oltre alla monografia di Linda Terziroli, Un pacchetto di Gauloises. Una biografia di Guido Morselli (Roma, Castelvecchi, 2019), si è fatto riferimento alla cronologia di Valentina Fortichiari per Guido Morselli, Romanzi, I, a cura di Elena Borsa, Sara D’Arienzo, con la collaborazione di Paolo Fazio, Milano, Adelphi, 2002 e, a cura della stessa, al libro Guido Morselli: immagini di una vita, con uno scritto di Giuseppe Pontiggia, Milano, Rizzoli, 2001 (a p. 41 la dichiarazione di Mario Morselli; a p. 101 la testimonianza di Dante Isella sul Dizionario dietetico). La citazione di Maria Corti è da Ombre dal fondo, Torino, Einaudi, 1997, p. 94; la lettera a Konrad Lorenz nelle Lettere ritrovate, a cura di Linda Terziroli, postfazione di Silvio Raffo, Varese, Nuova Editrice Magenta, 2009, pp. 125-126.